Le stagioni a Vigevano
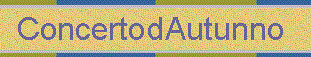
Opere liriche al Castello Sforzesco di Vigevano
luglio 2001 foto, presentazione
e commenti sulla manifestazione

W VERDI un solo grande amore!! La vita e i
libretti di tutte le sue opere.
|
Teatro Cagnoni di
Vigevano
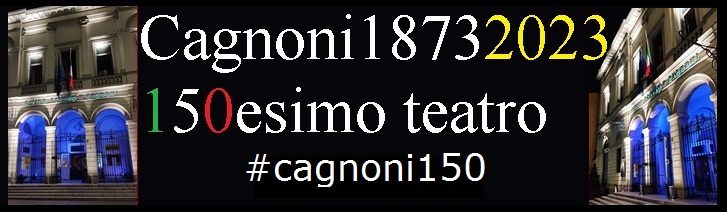
Ricordo di Antonio
Cagnoni
nel centenario della morte 11 dicembre 1996 Vigevano
Antonio Cagnoni
8 febbraio 1828 Godiasco (Pavia)
- 30 aprile 1896 Bergamo
maestro di cappella a Vigevano (1856) e a Bergamo (1888)
Cagnoni fu a Vigevano sino al 1879 quando
passò a Novara come successore di Carlo Coccia quale organista a San Gaudenzio
e poi nel 1888 passò a Bergamo in Santa Maria Maggiore come sostituto di A.
Ponchielli dove vi morì nel 1896.
La vena espressiva di Cagnoni si
realizzò compiutamente nel genere buffo che, attorno alla metà
dell’Ottocento, conobbe una rinnovata fortuna. A lui è dedicato il l Civico
Teatro Antonio Cagnoni di Vigevano di Vigevano (Pavia) dove
nell'ottobre 1875 vennero allestite due opere del cittadino vigevanese
d'adozione Antonio Cagnoni, il Papà Martin e il Don Bucefalo.
Di fronte ad un pubblico, purtroppo ridotto, si è tenuto a Vigevano un convegno
dedicato ad Antonio Cagnoni, a lui dedicato dalla città che lo ospitò per ben 21 anni,
come maestro di cappella della cattedrale. Nel centenario della morte ci si è ricordati
di un autore che fu cosi stimato dai contemporanei tanto da entrare nella lista dei
prescelti per la composizione di quel requiem a più mani che doveva essere scritto per la
morte di Rossini. Autore di diciassette opere liriche di cui nove nel genere buffo,
quattro in quello semiserio e quattro nel genere serio, ebbe come librettisti Romani(1),
C.Bassi(3), Ghislanzoni(4), M.Marcello(2), Piave(1), Tarantini(1), Giacchetti(3), Guidi(2)
e i suoi lavori furono rappresentati a Milano (8), Genova(4), Torino(3), Roma (1),
Lecco(1).
Nato a Godiasco il 8 febbraio 1828, fu maestro di cappella in cattedrale a Vigevano dal
1852 al 1873, a Novara dal 1873 al 1877, e a Santa Maria Maggiore a Bergamo sino alla
morte avvenuta il 30 aprile 1896; a lui venne dedicato il massimo teatro di Vigevano.
"Godette di una certa popolarità come operista" cosi viene liquidato da alcune
enciclopedie, e le sue opere citate sono Don Bucefalo(1847), Michele Perrin(1864), Papa
Martin (1871), Francesca da Rimini(1878)
Nel convegno vigevanese, i primi relatori hanno illustrato più il panorama musicale nel
quale visse che non piuttosto la sua figura; Sergio Martinotti ha aperto i lavori del
convegno delineando la storia de "Il comico nel teatro musicale dell'800"
partendo dal '700 con l'adagiarsi a schemi che diventavano sempre più obsoleti, fino al
re dell'opera napoletana, Paisiello, ed al nuovo astro rossiniano se pur fischiato alla
prima romana del Barbiere.
Un filone comico che passa attraverso il capolavori donizettiani del Don Pasquale e
Elisir; sin quando l'Italia si divide guardando da una parte al grande motore della
drammaturgia verdiana e dall'altro guardando oltralpe, con la scapigliatura, nella quale
domina forse più la cornice del contenuto. Quando il grand operà irrompe con lo sguardo
rivolto all'esotismo, Cagnoni da attento musicista, consapevole dei propri mezzi, si
dedica con onestà al recupero della comicità nel teatro d'opera.
Danilo Prefumo ha voluto sottolineare il valore della musica strumentale dell'800
italiano, dovuta in primo luogo a grandi strumentisti come Paganini, Rolla, Giuliani, che
portano avanti la tradizione nazionale di strumentisti e compositori quali Vivaldi,
Sammartini e Tartini, ma senza potere contrastare il predominio dell'opera lirica,
predominio indiscusso nel paese del bel canto, quasi che la mancanza di strumentisti fosse
compensata dalla sovrabbondanza dei librettisti al contrario di quanto succedeva nello
stesso periodo in Germania.
Alberto Cantù con la sua relazione "Il concertista va in scena" ha invece
sottolineato come molte volte il valore dell'opera fosse legato all'interprete e non tanto
al lavoro in se stesso, e come ai giorni nostri quando si tenta di recuperare un opera
dimenticata sarebbe opportuno verificare la validità degli interpreti scelti per non
sotterrare definitivamente il lavoro con un recupero mal fatto.
Terminati gli interventi che definirei di "assoluto contorno" nonostante il
"nome" dei relatori, siamo entrati nel merito della figura di A.Cagnoni con la
dott.ssa Maria Teresa Della Borra, che ha dimostrato di avere effettuato uno studio molto
approfondito della produzione musicale di Cagnoni, partendo da quei primi lavori di saggio
che gli venivano richiesti al Conservatorio come la "Rosalia di san Miniato"
(1847) o quel Don Bucefalo(1847) che fu il saggio di chiusura dei suoi studi, e che fu
coronato da "grandissimo successo" riconfermato in una successiva esecuzione a
Marsiglia, tanto che il Cagnoni fu subito notato dal Ricordi che se lo assicurò.
Quando affronta l'opera seria con la "Claudia"(1866) la critica la definisce
"grandiosa" e segnala "la fluidità della melodia che del moderno
si abbella del meglio", anche il Ghislanzoni la criticò molto favorevolmente.
Con "Papa Martin" inizia una fase ancora comica ma affrontata in modo diverso,
si sente l'influsso della scapigliatura, l'ambientazione povera, il lavoro, il risparmio,
i valori sociali, il comico (l'usuraio) unito al patetico( papà Martin) ne fa' un lavoro
di successo, a Genova fu replicata sino al 1900.
La sua "Francesca da Rimini", che fu rappresentata accanto a "Le Roj de
Lahore", ricevette critiche contrastanti, forse anche dovute agli interventi del
Ghislanzoni con l'inserimento di balli e parate; alcuni la giudicarono "essere
senza senso", altri segnalarono "l'intensa partecipazione, la fluidità
melodica" la "miglior resa del IV atto dove l'autore da il massimo",
e come l'autore fosse "melodista chiaro e fluido, decorato da spunti armonici",
in ogni caso fu ancora rappresentata per ben 20 anni.
Il suo disagio per il gusto imperante, è stato ben delineato dalla relazione del
vigevanese Carlo Ramella, che ha esaminato la numerosa produzione liturgica giacente
presso gli archivi vigevanesi, a Novara e Bergamo, in un periodo dove il riferimento ad
arie solistiche e a manomissioni del testo sacro per costruire affascinanti cattedrali
sonore, sollecitava l'attenzione della Chiesa che richiamava ad una maggiore aderenza
della musica sacra al proprio compito liturgico, il Cagnoni dimostrava "senso
giusto ed equilibrato nell'intendere il classico romano ideale della musica sacra"
a cui dovevano conformarsi gli autori. Non ha caso esistono "richiami" del
Capitolo per quegli organisti che fanno sentire troppo "l'opera" nelle loro
esecuzioni.
In ogni caso se Antonio Cagnoni non ebbe particolari interessi di ricerca per il nuovo, ha
approfondito le "vie note" curando i dettagli, approfondendo la chiarezza
del discorso musicale cercando di svincolarsi dal convenzionalismo, ed approfondendo il
linguaggio armonico.
Mario Mainino
OPERE
Ha scritto musica per orchestra da camera e vocale, musiche sacre (fra cui una
Messa da Requiem). Nacque nel 1828, lo stesso anno dei compositori Barthe,
Cossoul, Gevaert, Jouret, Luzzi, Platania, Poise, Rossi, Schubert, Siboni.
"Rosalia di S Miniato" venne rappresentata il 28 febbraio 1845 a Milano
(Conservatorio)
"I due savoiardi" venne rappresentata il 15 giugno 1846 a Milano (Conservatorio)
"Don Bucefalo", Melodramma giocoso in 3 Atti, venne rappresentata il 28 giugno
1847 a Milano (Conservatorio)
Don Bucefalo -Personaggi
Don Bucefalo, maestro di musica spiantato (Basso); Carlino, giovane militare
(Tenore); Rosa, sua presunta vedova (Soprano); Agata (Mezzosoprano) e Giannetta
(Soprano), contadine; Don Marco, benestante podagroso e spasimante di Rosa
(Basso); il conte di Belprato, amante di Rosa (Tenore); contadini e contadine
|
Martedì 22 Luglio 2008 Palazzo Ducale Martina Franca
DON BUCEFALO
melodramma giocoso in tre atti su libretto di Calisto Bassi
musica di Antonio Cagnoni
Prima esecuzione assoluta in tempi moderni
Edizione critica a cura di Anders Wiklund
Editore Casa Ricordi, Milano
Il Conte di Belprato: Aldo Caputo
Don Bucefalo: Filippo Morace
Gianetta: Francesca De Giorgi
Carlino: Massimiliano Silvestri
Don Marco: Graziano De Pace
Rosa: Angelica Girardi
Agata: Date Mizuki
Coro Slovacco di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia
direttore: Massimiliano Caldi
regia: Marco Gandini
scene: Italo Grassi
costumi: Silvia Aymonino
Edizione discografica
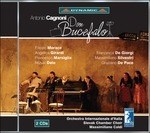
Etichetta Dynamic Prezzo € 29,90
|
|
Don Bucefalo di Antonio Cagnoni, prima esecuzione in
tempi moderni, è la seconda opera in scena al Festival della Valle
d’Itria, domani 20 luglio, inizio ore 21.00.
Intorno alla metà dell’ottocento il genere buffo conobbe una particolare
fortuna ed in questo periodo, fra una moltitudine di operisti minori
italiani, Antonio Cagnoni (Godiasco, Pavia 1828 – Bergamo 1896) raggiunse
in età giovanile una grande notorietà, toccando l’apice della sua vena
espressiva grazie a uno spartito proprio di genere giocoso, il Don
Bucefalo.
Parafrasata dalle Cantatrici villane di Valentino Fioravanti, l’opera si
caratterizzò nel ricco filone dei soggetti legati alla satira sul teatro
in musica. La goffa figura del protagonista, un maestro di cappella
borioso e spietato, divenne un cavallo di battaglia del celebre basso
buffo Alessandro Bottero, che nel 1865 fece approdare l’opera a Parigi,
andata in scena per la prima volta al Conservatorio di Milano il 28 giugno
1847. Ma Cagnoni, sfruttando con oculatezza le formule del genere buffo,
seppe mettere alla prova bassi ciarlieri, tenori e soprani lirici,
ricorrendo anche a dialoghi in dialetto napoletano e a una scrittura
strumentale sorprendentemente densa.
Tra le pagine più riuscite dell’opera (che fu ripresa con successo a
Milano al Teatro Re nel 1847, alla Scala nel ’48 e al Carcano nel ’49,
fino a un’esecuzione americana nel 1867 di cui dà notizia il New York
Times dell’epoca) spiccano il quartetto "Io dirò se nel gestire", l’aria
"Ah! figliuol; date mente" (Don Bucefalo), il concertato "Chi mi ha tolto,
poveretta" (finale del secondo atto) e la gustosissima scena della prova
d’orchestra "Trai, trai, trai, larà larà" (Don Bucefalo).
Don Bucefalo ode cantare alcune contadine di Frascati e ne rimane colpito;
offre loro lezioni di canto, lusingandole con promesse di gloria.
Giannetta, Agata e Rosa abboccano; quest’ultima si consola della presunta
vedovanza da Carlino, con il conte di Belprato e con il vecchio Don Marco.
Ma Carlino torna inaspettatamente e apprende degli intrighi amorosi. La
vicenda si snoda quindi tra i battibecchi delle contadine, che si
contendono il ruolo di ‘prima donna’, le peripezie dei loro amanti e le
velleità artistiche di Bucefalo; il culmine giunge nel terzo atto,
allorché il maestro di musica allestisce la sua nuova opera. Rosa ne è la
‘prima donna’ ma, proprio al momento della sua entrata in scena, ecco
comparire Carlino che reclama la moglie, creando lo scompiglio generale.
Don Bucefalo si dispera per il fallimento della prova; Agata e Giannetta,
invidiose di Rosa, esultano per la sua imminente punizione; il conte
trema. Naturalmente tutto finisce per il meglio e Rosa si pente, giurando
fedeltà al marito ritrovato. L’opera sarà trasmessa in diretta su radio 3
Suite. L’edizione rappresentata sarà pubblicata su CD. |
|
Martina Franca, Palazzo Ducale, Info. 080.4805 100
http://www.festivaldellavalleditria.it |
| La recensione di Mirko Bertolini Martina Franca (TA),
palazzo ducale Don
Bucefalo di Antonio Cagnoni
"Negli anni cinquanta"
tratto da:
http://www.teatro.org/spettacoli/nuovo/don_bucefalo_1110_11211
Il Festival della Valle d’Itria di Martina Franca,
giunto alla sua 34esima edizione, ha il grande pregio di presentare ogni
anno al pubblico titoli in prima esecuzione nei tempi moderni, riscoprendo
non solo titoli passati nel dimenticatoio ma anche autori che, già noti
nei loro tempi, ora non ricorda quasi nessuno. Quest’anno, accanto al Re
pastore, musicato da Niccolò Piccinni su libretto del Metastasio e al
Pelagio di Saverio Mercadante, è stata rappresentata il Don Bucefalo,
opera giovanile del compositore lombardo Antonio Cagnoni (1828 – 1896).
Il Cagnoni, compositore che nella folta schiera degli operisti
minori dell’Ottocento italiano, spesso ingiustamente dimenticati,
occupa un posto di rilevo, scrisse numerose opere che incontrarono il
favore del pubblico, soprattutto nei teatri di Torino e Milano. Solo
una ebbe, però un notevole successo, Don Bucefalo, composta nel 1847 ad
appena 19 anni come saggio finale dei suoi studi al Conservatorio di
Milano.
Il lavoro, che doveva essere solo il saggio di fine anno scolastico, fece
improvvisamente catapultare il Cagnoni al centro di un successo europeo
destinato a durare per decenni.
La vena espressiva di Cagnoni si realizzò compiutamente nel genere
buffo che, attorno alla metà dell’Ottocento, conobbe una rinnovata
fortuna; a questo particolare momento appartiene Don Bucefalo.
Don Bucefalo è un maestro di cappella borioso, che
giunge a portare scompiglio in una comunità di contadini, realizzando gags
molto divertenti che, oltre ad innegabili doti canore, richiedono anche
una notevole capacità interpretativa sul piano recitativo. Il maestro ode
cantare alcune contadine di Frascati e ne rimane colpito; offre loro
lezioni di canto, lusingandole con promesse di gloria. Giannetta, Agata e
Rosa abboccano; quest’ultima si consola della presunta vedovanza con il
conte di Belprato e con il vecchio Don Marco. Carlino, il marito, torna
inaspettatamente e apprende di quegli intrighi amorosi. La vicenda si
snoda tra i battibecchi delle contadine, che si contendono il ruolo di
prima donna, le peripezie dei loro amanti e le velleità artistiche di
Bucefalo; il culmine giunge nel terzo atto, allorché il maestro di musica
allestisce la sua nuova opera. Rosa ne è la prima donna ma, proprio al
momento della sua entrata in scena, ecco comparire Carlino che reclama la
moglie, creando lo scompiglio generale. Don Bucefalo si dispera per il
fallimento della prova; Agata e Giannetta, invidiose di Rosa, esultano per
la sua imminente punizione; il conte trema. Naturalmente tutto finisce per
il meglio e Rosa si pente, giurando fedeltà al marito ritrovato.
La trama segue il modello del teatro nel teatro
che riporta a una diffusa tradizione volta a rappresentare il mondo del
teatro lirico dell’epoca, di cui mostra le dinamiche creative e produttive
in una situazione di burla. Ne viene fuori un’opera che è ricolma di
trovate musicali e drammaturgiche. Sebbene attinga alla tradizione più
consolidata dell’opera buffa italiana (bassi ciarlieri, tenori e soprani
lirici, cavatine in due movimenti senza il tempo di mezzo, ricorso al
recitativo secco e ai dialoghi in dialetto napoletano), facendone propri
gli schemi, dai ruoli vocali fino alla scrittura dei recitativi, riesce a
rielaborarla alla luce dell’evoluzione del linguaggio musicale di quegli
anni e di una fantasia quanto mai fervida.
Molteplici dunque gli echi della tradizione (da
Paisiello a Cimarosa, a Rossini, a Donizetti, al giovane Verdi) di cui il
giovanissimo compositore dimostra una sorprendente padronanza: molti,
ascoltando Don Bucefalo avranno ricordato l’Elisir d’amore oppure Il
signor Bruschino.
Colpisce la capacità di strumentazione, una
scrittura vocale dagli esiti virtuosistici e brillanti, una felice
capacità di amalgamare voci e orchestra, una vena melodica accattivante e
un serrato andamento ritmico che non lascia spazio alla noia.
Alcuni dei momenti più esilaranti dello
spettacolo sono la lezione di canto che occupa gran parte del primo
atto o, nel secondo, la fase in cui Don Bucefalo concepisce la
partitura per la nuova opera di tema storico antico romano, tentando
di costruire la frase musicale sulla musicalità e sul ritmo del testo per
poi passare alla concertazione strumentale dell’orchestra.
Un momento che fornisce all’interprete di Don Bucefalo
l’occasione di mettere in campo tutte le sue doti di attore, essenziali
per rendere al meglio tutta la scena.
Il regista Marco Gandini ha riletto l’opera
ambientandola, tra l’altro senza scadere nel banale o nell’incongruo,
nella campagna romana degli anni cinquanta del secolo passato, anni in
cui nasceva il desiderio di fare successo nel mondo dello spettacolo; ne è
risultata una regia dinamica e scorrevole, che ha dato giusto
rilievo alla comicità dell’opera buffa.
Semplici le scene di Italo Grassi, consistenti
in un lungo muro esterno, sulla strada Roma – Frascati, che diventa
volta a volta stanza da letto, sala prove, palcoscenico del teatro nel
teatro.
Belli e intonati alle scene i costumi di Silvia
Aymonino.
La partitura è stata resa con il giusto equilibrio
dall’Orchestra Internazionale d’Italia, diretta egregiamente dal
Massimiliano Caldi.
Omogeneo e ben affiatato il cast che ha visto
primeggiare il basso-baritono Filippo Morace nel ruolo di Don
Bucefalo, che è riuscito senza cedimenti a catturare l’attenzione e
l'entusiasmo del pubblico, anche per la grande presenza scenica come
buffo. Bravi anche gli altri interpreti: il soprano Angelica Girardi nel
ruolo di Rosa, il Conte di Belprato del tenore Francesco Marsiglia, il
mezzosoprano leccese Francesca De Giorgi in Giannetta e il baritono
Graziano De Pace in Don Marco.
Disomogenea nel colore e nella consistenza la voce del
soprano Mizuki Date nel ruolo di Agata, che inoltre non ha curato a
sufficienza la parte espressiva, così pure poco omogenea ed eccessivamente
debole nel confronto con la massa sonora dell’orchestra, la voce del
tenore Massimiliano Silvestri nelle vesti di Carlino.
Buona la prova del Coro Slovacco di Bratislava
guidato da Pavol Prochazka. Tutto esaurito per le due rappresentazioni e
successo decretato da un pubblico sempre più internazionale ma
chiacchierone, in una serata fredda e notevolmente ventosa.
Visto a Martina Franca (TA), palazzo ducale, il 22
luglio 2008 Mirko Bertolini |
| |
|
Don Bucefalo
di Piero Gelli (11:49 - 31 lug 2008)
tratto da :
http://delteatro.it/articoli/2008-07/il-re-pastore-e-don-bucefalo.php
È sempre un piacere venire a Martina Franca per il Festival della valle
d'Itria, non solo perché la cittadina è bellissima e la gentilezza di chi
ci ospita squisita, ma perché si mettono in scena opere rare, spesso in
prima esecuzione assoluta in tempi moderni, come quest'anno: Il re pastore
di Niccolò Piccinni (Bari 1728 - Passy 1800), Don Bucefalo di Antonio
Cagnoni (Pavia 1828 - Bergamo 1896) e Pelagio di Saverio Mercadante (Altamura
1795 - Napoli 1870). Ho visto le prime due. [ ...]
Il pubblico fedele, forse un po' tediato dai tono melanconici della
musica di Piccinni e dalla lunghezza dell'opera, è stato ampiamente
ricompensato dall'opera seconda in programma, di sfrenato godimento e
divertimento. Si tratta del Don Bucefalo di Antonio Cagnoni.
Cagnoni oggi sconosciuto, nel suo secolo, l'Ottocento, era famoso e
apprezzato; tra l'altro anche da Giuseppe Verdi. Questo melodramma
giocoso, lui lo scrisse a diciannove anni, come saggio del suo cursus
studiorum al Conservatorio di Milano nel 1847. Il successo fu clamoroso; e
crebbe ancora e durò per tutta la vita del compositore e soprattutto del
grande basso che nel ruolo di Don Bucefalo si specializzò in trovate e
improvvisate, Alessandro Bottero.
Curiosamente, con la morte di entrambi, l'opera venne dimenticata, e
ingiustamente, perché è piena di verve, di ritmo e di finezze espressive.
Certamente l'opera buffa rientra nel genere ben calibrato delle parodie
metateatrali (la derivazione da Le cantatrici villane di Fioravanti
è palese; e si ricordi Le convenienze e inconvenienze teatrali
donizzettiane) e gli echi di Donizetti e dei concertati rossiniani
risuonano negli orecchi, ma nulla tolgono al piacere dell'ascolto,
anzi lo accrescono nella conferma di un talento artigiano di grande
livello.
Si pensa, vedendo lo spettacolo, che cosa non sarebbe stato se l'avesse
cantato un Sesto Bruscantini.
Perché tutto il gioco è nelle mani dell'arruffone maestro di cappella Don
Bucefalo, qui interprato con successo da Filippo Morace; assecondato con
grazia dal soprano Angelica Girardi.
La regia di Marco Gandini, bravissimo, ha con intelligenza e arguzia
ambientato la vicenda nella Cinecittà degli anni Cinquanta: e a un
certo momento il muro che taglia la scena per lungo si riempie di
manifesti di celebri film peplo dell'epoca, da Fabiola a Quo Vadis.
Quanto alla partitura, non poteva trovare un migliore interprete del
maestro Massimiliano Caldi, che l'ha diretta con tale spigliatezza,
sottigliezza, brio e precisione, che mi chiedo per quale motivo egli,
milanese di nascita e (credo) di residenza, non sia mai stato invitato
alla Scala: Nemo propheta in Patria. |
| Rassegna stampa |
Massimiliano Caldi ha diretto una prima esecuzione assoluta in
tempi moderni del Don Bucefalo di Antonio Cagnoni al Festival della Valle
d'Itria di Martina Franca.
Travolgente opera buffa di metà Ottocento, Don Bucefalo si inserisce
nel ricco filone dei soggetti legati alla satira sul teatro in musica.
Composto da un giovanissimo Antonio Cagnoni, aveva solo 19 anni, come
saggio del suo cursus studiorum al Conservatorio di Milano nel 1847, il
successo di quest'opera fu clamoroso e crebbe e durò per tutta la vita del
compositore e del grande basso Alessandro Bottero che nel ruolo di Don
Bucefalo si specializzò in trovate e improvvisate.
Don Bucefalo ode cantare alcune contadine di Frascati e ne rimane colpito;
offre loro lezioni di canto, lusingandole con promesse di gloria.
Giannetta, Agata e Rosa abboccano; quest'ultima si consola della presunta
vedovanza da Carlino, con il conte di Belprato e con il vecchio Don Marco.
Ma Carlino torna inaspettatamente e apprende degli intrighi amorosi. La
vicenda si snoda quindi tra i battibecchi delle contadine, che si
contendono il ruolo di prima donna, le peripezie dei loro amanti e le
velleità artistiche di Bucefalo; il culmine giunge nel terzo atto,
allorché il maestro di musica allestisce la sua nuova opera. Rosa ne è la
prima donna ma, proprio al momento della sua entrata in scena, ecco
comparire Carlino che reclama la moglie, creando lo scompiglio generale.
Don Bucefalo si dispera per il fallimento della prova; Agata e Giannetta,
invidiose di Rosa, esultano per la sua imminente punizione; il conte
trema. Naturalmente tutto finisce per il meglio e Rosa si pente, giurando
fedeltà al marito ritrovato.
Regia di Marco Gandini, che con intelligenza e arguzia ha ambientato la
vicenda nella Cinecittà degli anni Cinquanta. Scene di Italo Grassi,
costumi di Silvia Aymonino.
Interpreti Angelica Girardi (Rosa), Massimiliano Silvestri (Carlino),
Filippo Morace (Don Bucefalo), Date Mizuki (Agata), Francesca De Giorgi (Gianetta),
Graziano De Pace (Don Marco), Francesco Marsiglia (Il Conte di Belprato).
Coro Slovacco di Bratislava, Orchestra Internazionale d'Italia.
Dalla stampa:
«Prodotto di pregevole fattura musicale - nella sua moderna concezione di
teatro nel teatro - il Don Bucefalo di Martina Franca si é avvantaggiato
della limpida direzione d'orchestra di Massimiliano Caldi e
dell'esilarante impianto visivo di Marco Gandini.»
(Classic Voice - settembre 2008 - Francesco Arturo Saponaro)
«Alla direzione vibrante e incisiva di Massimiliano Caldi si uniscono le
virtù di spigliatezza e simpatia di un gruppo di giovani e validi
interpreti in uno spettacolo divertente e arguto, accolto da meritate
ovazioni.»
(Amadeus - ottobre 2008 - Gildo Salerno)
«In buca, Massimiliano Caldi coglie la palla al balzo: conduce l'operina
con raffinato gusto. I tempi sempre giusti corrono ora veloci ed ora si
allargano in delicate oasi liriche, con un'attenzione ben calcolata alle
sfumature, ma anche alle naivité di un lavoro che del saggio finale
conserva la freschezza.
Caldi accompagna con intelligenza i cantanti. Pur prestandosi alla
commedia, non permette che lo stile comico si incrosti di caccole che,
care forse al gusto ottocentesco, quando il Don Bucefalo era il cavallo di
battaglia di noti buffi, oggi non sarebbero sopportabili.»
(L'Opera - settembre 2008 - Giancarlo Landini)
«E il prodigio consiste nella riscoperta del gioco assoluto rossiniano di
là del binario morto di una ormai impossibile mera imitazione. A
cominciare dalla squisita scrittura orchestrale, vero omaggio postumo ai
procedimenti formali dei grandi del passato, intesi non come calchi ma
come ideali ripensamenti. Ciò che benissimo ha compreso il direttore
Massimiliano Caldi, un tipo da tener d'occhio: eleganza di fraseggio,
finissima calibratura sonora di timbrica, vigile partecipazione a quella
che sembra la qualità specifica di quella musica, la classica concisione
di dettato.»
(sipario.it - 28 luglio 2008 - Giovanni Carlo Ballola)
(Il Mattino - 28 luglio 2008 - Giovanni Carlo Ballola)
(Espresso - 13 agosto 2008 - Giovanni Carlo Ballola)
«A dirigere con precisione l'Orchestra Internazionale d'Italia
Massimiliano Caldi.»
(Taranto Sera - 21 luglio 2008 - Daniele Lo Cascio)
«(...) Don Bucefalo era incalzato dall'esuberante spettacolo di Marco
Gandini ambientato nella Roma anni '50, nel clima del film in costume (la
smaliziata scena é di Italo Grassi) e dalla direzione di Massimiliano
Caldi, che ha spronato con garbo la giocosa compagnia di canto, tra cui
spiccavano Filippo Morace e Angelica Girardi»
(La Repubblica - 21 luglio 2008 - Angelo Foletto)
«Esemplare poi l'accordo realizzato fra il direttore Massimiliano Caldi ed
il regista Marco Gandini. Alla direzione fervida e dinamica di Caldi -
capace fra l'altro di valorizzare in pieno la rimarchevole eleganza e
raffinatezza della partitura, offrendo alle voci l'equilibrato supporto -
ha fatto riscontro l'azione teatrale ...»
(La Gazzetta del Mezzogiorno - 22 luglio 2008 - Nicola Sbisà)
«Sempre sotto la direzione del brioso Massimiliano Caldi, a lungo
applaudito dal pubblico con gli altri protagonisti»
(Corriere del Mezzogiorno - 22 luglio 2008 - Francesco Mazzotta)
«L'Orchestra Internazionale d'Italia, dopo "Re Pastore", l'opera seria dei
giorni scorsi, é passata con grande professionalità all'opera buffa di
Cagnoni, diretta con slancio ed eleganza dall'eccelente Massimiliano Caldi
che ha conferito i giusti, agili ritmi e il necessario smalto a un’opera
piacevolissima in ogni battuta. Perfetto l'aggancio orchestra e
palcoscenico e armoniosa la fusione tra suoni e voci.»
(Corriere del Giorno - Taranto - 22 luglio 2008 - José Minervini)
«Ottima la direzione di Massimiliano Caldi sul podio dell'Orchestra
Internazionale d'Italia (...)»
(Nuovo Quotidiano di Puglia - 22 luglio 2008 - Eraldo Martucci)
(nireo.it - 22 luglio 2008 - Eraldo Martucci)
«L'Orchestra Internazionale d'Italia é stata la vera protagonista del
Festival sia nel "Re Pastore" sia nel "Don Bucefalo", vuoi per l'insolita
bellezza del suono, vuoi per l'impeccabile precisione, qualità messe in
risalto dai rispettivi direttori: nel primo caso Giovanni Battista Rigon,
specialista del repertorio barocco e nel secondo caso Massimiliano Caldi,
già apprezzato nella scorsa "Salomè&#quot;.»
(ilgallo.org - 25 luglio 2008 - Fernando Greco)
«A Martina Franca il Festival della Valle d’Itria ha fatto rivivere la
sicurezza e la disinvoltura con cui il giovanissimo Cagnoni si inserisce
nella grande tradizione comica italiana da Rossini a Donizetti, guardando
soprattutto a quest’ultimo, giocando con garbo sui temi della vecchia
satira dei compositori e su situazioni note, ma sempre risolte
piacevolmente. Lo hanno fatto capire la sciolta e pertinente direzione di
Massimiliano Caldi, la bella regia di Marco Gandini ...»
(L'Unità - 28 luglio 2008 - Paolo Petazzi)
«Sul podio della brillante Orchestra Internazionale d'Italia, il maestro
Massimiliano Caldi é riuscito a governare lo spettacolo con abilità,
valorizzando l'eleganza e la freschezza cantabile che vivono nella
partitura, calcando l'accento della comprensibilità delle pagine dove
maggiormente sono evidenti i richiami agli "evangelisti" dell'operismo
italiano ottocentesco (Rossini, Bellini, Donizetti e il "primo" Verdi),
garantendo una resa del contesto strumentale nitida corroborando il tutto
con mordente vivacità ritmica.»
(operaclick.com - 22 luglio 2008 - Dino Foresio)
«(...) con il direttore Massimiliano Caldi in ottima forma.»
(giornaledellamusica.it - luglio 2008 - Fiorella Sassanelli)
«Quanto alla partitura non poteva trovare un miglior interprete del
maestro Massimiliano Caldi, che l'ha diretta con tale spigliatezza,
sottigliezza, brio e precisione, che mi chiedo per quale motivo egli,
Milanese di nascita e residenza, non sia mai stato invitato alla Scala:
Nemo propheta in Patria.»
(delteatro.it - 31 luglio 2008 - Piero Gelli)
«I virtuosismi belcantistici sono valorizzati da una buona compegnia di
giovani interpreti, tra cui spiccano il soprano Angelica Girardi e il
tenore Francesco Marsiglia, con il direttore Massimiliano Caldi in ottima
forma.»
(giornaledellamusica.it - luglio 2008 - Fiorella Sassanelli)
«La partitura é stata resa con il giusto equilibrio dall'Orchestra
Internazionale d'Italia, diretta egregiamente da Massimiliano Caldi.»
(teatro.org - luglio 2008 - Mirko Bertolini)
«Una partitura caleidoscopica resa con il giusto equilibrio dall'Orchestra
Internazionale d'Italia, diretta con energia e grande perizia da
Massimiliano Caldi.»
(cannibali.it - luglio 2008 - Enzo Garofalo) |
| |
|
Don Bucefalo di
Cagnoni: spassosa ‘rivelazione’
al Festival della Valle d’Itria di Enzo Garofalo
Tratto da :http://www.cannibali.it/leggi.php?n=1&i=334&c=2
Si è presentata come una piacevole ventata di
freschezza, nonostante la sua veneranda età (la prima esecuzione
risale al 1847) l’opera “Don Bucefalo” del compositore lombardo Antonio
Cagnoni, andata in scena il 20 luglio presso il Palazzo Ducale di Martina
Franca nell’ambito del 34° Festival della Valle d’Itria, in prima
esecuzione assoluta per i tempi moderni, nell’edizione critica di Anders
Wiklund.
Melodramma giocoso in tre atti su libretto di Calisto Bassi ha la
peculiarità di rappresentare il vero esordio da ‘enfant prodige’ di un
Cagnoni appena diciannovenne. Entrato al Conservatorio di Milano a 14 anni
avrebbe rivelato presto un grande talento musicale con particolari doti
per il teatro, destinate a raggiungere l’apice in questo lavoro che doveva
essere il saggio di fine anno e che invece lo fece improvvisamente
ritrovare catapultato al centro di un successo europeo destinato a durare
per decenni. Dall’iniziale gruppo di studenti e cantanti locali si sarebbe
infatti presto passati ad affidarne l’esecuzione ad una compagnia di
professionisti, tra i quali il basso comico Alessandro Bottero che, nel
ruolo di Don Bucefalo, avrebbe unito il suo nome a quello di Cagnoni per
un trentennio.
Don Bucefalo è un maestro di cappella borioso, che giunge a portare
scompiglio in una comunità di contadini, dando vita a gags molto
divertenti che oltre ad innegabili doti canore richiedono anche una
notevole capacità interpretativa sul piano attoriale. Il maestro ode
cantare alcune contadine di Frascati e ne rimane colpito al punto da
proporre loro lezioni di canto, lusingandole con promesse di successo. Ad
abboccare per prime Rosa, Giannetta e Agata. La prima in particolare,
presunta vedova, tra un esercizio canoro e l’altro accetta la corte del
conte di Belprato e di Don Marco. Ma il marito Carlino torna inaspettato e
apprende degli intrighi amorosi. E’ così che tra battibecchi delle
contadine, pronte a contendersi il ruolo di ‘prima donna’, le goffe
schermaglie dei loro amanti ed i progetti artistici di Don Bucefalo, la
vicenda giunge al culmine nel terzo atto, col maestro di musica pronto ad
allestire la sua nuova opera. Rosa sarà la ‘prima donna’, ma ecco che
proprio al momento della sua entrata in scena, riappare Carlino deciso a
riprendersi la moglie, tra lo scompiglio generale. Don Bucefalo si trova
di fronte al fallimento della prova dello spettacolo, mentre Agata e
Giannetta, rivali di Rosa, gioiscono per la situazione imprevista ed il
conte paventa le rappresaglie di Carlino. Ma tutto finisce per il meglio e
Rosa pentita, giura fedeltà al ritrovato marito.
La trama, seguendo il modello del ‘teatro nel teatro’ riporta ad una
diffusa tradizione volta a rappresentare il mondo del teatro lirico
dell’epoca di cui mostra, a volte parodisticamente, le dinamiche
creative e produttive. Ne viene fuori un’opera che è un vero e proprio
tripudio di trovate musicali e drammaturgiche e, sebbene attinga alla
tradizione più consolidata dell’opera buffa italiana facendone propri gli
schemi, a partire dai ruoli vocali fino alla scrittura dei recitativi,
riesce a rielaborarla alla luce della evoluzione del linguaggio musicale
di quegli anni e di una fantasia quanto mai fervida, caratteristiche che
da parte di molti critici fecero considerare Cagnoni il vero
rivitalizzatore dell’opera comica. Molteplici dunque gli echi della
tradizione (da Paisiello a Cimarosa, a Fioravanti – delle cui
Cantatrici Villane Cagnoni parafrasa il libretto - a Rossini, a Donizetti)
di cui il giovanissimo compositore dimostra una sorprendente padronanza,
in un lavoro che se non è l’unico a collocarsi nel lasso di tempo
intercorso tra il ‘Don Pasquale’ di Donizetti ed il ‘Falstaff’ di Verdi,
fu quello che riuscì più di altri a dominare le scene per decenni.
Purtroppo Don Bucefalo rimane l'unica punta di diamante della produzione
di Cagnoni.
A colpire di quest’opera godibilissima, che ha buone premesse per un
futuro rientro nei cartelloni dei teatri d'opera, sono soprattutto una
capacità straordinaria di strumentazione, una scrittura vocale dagli esiti
virtuosistici e brillanti, una felice capacità di amalgamare voci ed
orchestra, una vena melodica accattivante ed un serrato andamento ritmico
che non lascia spazio alla noia. Alcuni dei momenti più esilaranti
dello spettacolo sono la ’lezione di canto’ che occupa gran parte del
primo atto o, nel secondo atto, la fase in cui Don Bucefalo concepisce la
partitura per la nuova opera di tema storico antico romano, allorchè prova
a declamare i versi, tentando di costruire la frase musicale sulla
musicalità e sul ritmo del testo per poi passare alla concertazione
strumentale dell’orchestra. Un momento di grande felicità compositiva che
fornisce all’interprete di Don Bucefalo l’occasione di mettere in campo
tutte le sue doti di attore, essenziali per rendere al meglio tutta la
scena. Per il resto l’opera è un piacevolissimo insieme di arie,
ensembles, recitativi semplici o accompagnati e dialoghi parlati, in
cui si manifesta con vigore la vena melodica e brillante di Cagnoni: una
partitura caleidoscopica resa con il giusto equilibrio dall’Orchestra
Internazionale d’Italia, diretta con energia e grande perizia dal M°
Massimiliano Caldi.
Gli interpreti di questa prima edizione moderna di ‘Don Bucefalo’ hanno
senz’altro contribuito nell’insieme alla riuscita dello spettacolo,
sebbene il valore del cast fosse abbastanza disuguale. Dotato di
indiscutibili doti interpretative e di un bel timbro vocale, il basso
baritono Filippo Morace, nel ruolo di Don Bucefalo, è riuscito senza
cedimenti a catturare l’attenzione e l'entusiasmo del pubblico, sebbene
nelle note più gravi la voce tendesse ad annullarsi nel suono
dell’orchestra. Scenicamente spigliata il soprano Angelica Girardi, nel
ruolo di Rosa, ha vocalmente affrontato la prova, a tratti complessa, con
sicurezza e precisione. Molto valida anche l’interpretazione del tenore
Francesco Marsiglia, nel ruolo del Conte di Belprato, sciupafemmine
impenitente, che ha cantato con voce squillante, elegante fraseggio e
musicalità. Disomogenea nel colore e nella consistenza la voce del soprano
Mizuki Date nel ruolo di Agata, che inoltre non ha curato a sufficienza la
parte espressiva. Poco omogenea ed eccessivamente leggera nel confronto
con la massa sonora dell’orchestra, la voce del tenore Massimiliano
Silvestri, sebbene sia stato convincente dal punto di vista scenico. Buona
la performance del mezzosoprano Francesca De Giorgi e del baritono
Graziano De Pace, rispettivamente nel ruolo di una procace Giannetta e di
un divertentissimo Don Marco. Ottimo il contributo del Coro Slovacco di
Bratislava, a cui la partitura riserva un ruolo di primo piano e che è
stato sapientemente guidato dal M° Pavol Prochazka.
Di grande dinamicità ed accuratezza la regia di Marco Gandini, puntata
sulla centralità della ‘lezione di canto’, con via vai di leggii e
spartiti, e sulla scorrevolezza di una comicità riletta in chiave di
commedia all’italiana anni ’50 - periodo al quale si sono uniformati
anche i bei costumi di Silvia Aymonino - fino alla scena finale dedicata
alle prove dell’opera-kolossal, in un affascinante mix di palcoscenico e
set cinematografico tipo Cinecittà. Perfettamente coerenti col resto le
scene di Italo Grassi, consistenti in un lungo muro esterno, lungo il
percorso Roma – Frascati, munito di insegne stradali d’epoca e che,
attraverso dei moduli trasversali semoventi diventa volta a volta anche
stanza, sala di lezione, set teatrale stracolmo di riflettori e manifesti
d’epoca.
Entusiastici gli applausi del pubblico (con qualche isolato fischio su
alcune uscite) che hanno richiamato più volte al proscenio tutti gli
artisti.
[garofalo@aliamedia.it ] |
"Il testamento di Figaro" è andata in scena il 26 febbraio
1848 a Milano (Teatro Re)
"Amori e trappole" è andata in scena il 27 aprile 1850 a Genova
"Il sindaco babbeo" venne rappresentata il 3 marzo 1851 a Milano (Teatro San
Radegonda)
"La valle d'Andorra" è andata in scena il 7 giugno 1851 a Milano (Teatro della
Cannobiana)
"Giralda" è andata in scena l'8 maggio 1852 a Milano (Teatro San Radegonda)
"La fioraia" è andata in scena il 24 novembre 1853 a Torino (Teatro Nazionale)
"La figlia di Don Liborio" venne rappresentata a Genova il 18 ottobre 1856
"Il vecchio della montagna, ossia L'Emiro" è andata in scena a Torino il 5
settembre 1860 (Teatro Carignano)
"Michele Perrin" venne rappresentata il 7 maggio 1864 a Milano (Teatro San
Radegonda)
"Claudia" è andata in scena il 20 maggio 1866 a Milano (Teatro della Cannobiana)
"La tombola" venne rappresentata il 18 gennaio 1867 a Roma (Teatro Argentina)
"Gli amori di Cleopatra" è stata eseguita nel 1870
"Un capriccio di donna" è andata in scena il 10 marzo 1870 a Genova
"Papà Martin" (The Porter of Havre) è andata in scena a Genova il 4 marzo 1871
"Il duca di Tapigliano" venne rappresentata a Lecce il 10 ottobre 1874
"Francesca da Rimini" venne rappresentata il 19 febbraio 1878 a Torino (Teatro
Regio)
"Il re Lear" è stata eseguita nel 1893.
|
RADIO3 SUITE - FESTIVAL DEI FESTIVAL
DOMENICA 19 LUGLIO 2009 ore 21.00
Martina Franca, Palazzo Ducale, 19 e 21 luglio 2009 ore 21,00
In diretta Euroradio
Palazzo Ducale di Martina Franca
35° FESTIVAL DELLA VALLE D'ITRIA
RE LEAR
Tragedia lirica in quattro atti e sette parti su libretto di
Antonio Ghislanzoni
musica di Antonio Cagnoni
edizione critica a cura di Anders Wiklund
Prima esecuzione assoluta
PERSONAGGI-INTERPRETI
Cordelia: Serena Daolio
Re Lear: Costantino Finucci
Edgardo: Danilo Formaggia
Regana: Eufemia Tufano
Conte di Gloster: Vladimer Mebonia
Il Matto: Rasha Talaat
Gonerilla: Maria Leone
Il Duca di Cornovaglia: Omar Jokhadze
Il Conte di Kent: Domenico Colaianni
Edmondo: Cristian Camilo Navarro Diaz
Orchestra Internazionale d'Italia
Coro Slovacco di Bratislava
Direttore d'orchestra: Massimiliano Caldi
Regia: Francesco Esposito
Scene: Nicola Rubertelli
Costumi: Maria Carla Ricotti
Coreografie: Mario Piazza

RADIO TRE Il libretto è
presente sul sito del FESTIVAL in formato .pdf
Edizione discografica
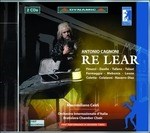
Etichetta Dynamic Prezzo € 29,90
|
|
35° FESTIVAL DELLA VALLE D’ITRIA
16 LUGLIO – 5 AGOSTO
PALAZZO DUCALE – MARTINA FRANCA
Prima rappresentazione mondiale
Secondo titolo d'opera in programma al Festival della Valle d'Itria, Re
Lear, l'ultima opera musicata da Antonio Cagnoni (Godiasco, 8 agosto
1828 - Bergamo 30 aprile 1896). Compositore dai meriti molto maggiori
di quanto riportino le storie della musica e tratta dalla tragedia
in cinque atti, in versi e prosa, Re Lear scritta tra il 1605 ed il 1606
da William Shakespeare. Mettere in musica il Re Lear fu anche il sogno
maturo che Verdi non riuscì a portare a termine. La storia trascritta
dal celebre librettista Antonio Ghislanzoni nel 1885, fu composta dal
Cagnoni nel 1893 ma non fu mai rappresentata vivente l'autore. Narra le
gesta di Re Lear, leggendario sovrano della Britannia che,
approssimandosi la vecchiaia, decide di dividere la Britannia fra le sue
tre figlie e i mariti che egli avrebbe loro assegnati, pur mantenendo
l'autorità regale. Il Re Lear è una novità assoluta: pur essendo di
grande interesse nell'evoluzione del melodramma italiano della fine
dell'Ottocento, ricco di influssi del tardo romanticismo europeo e del
movimento della Scapigliatura, non aveva mai visto le scene a causa
della morte del compositore subito dopo aver completato la partitura.
|
|
L'ultima opera musicata da Antonio Cagnoni (Godiasco,
8 agosto 1828 - Bergamo 30 aprile 1896) compositore dai meriti molto
maggiori di quanto riportino le storie della musica e tratta dalla
tragedia in cinque atti, in versi e prosa, "Re Lear" scritta tra il 1605
ed il 1606 da William Shakespeare. Mettere in musica il Re Lear fu anche
il sogno maturo che Verdi non riuscì a portare a termine. L'opera di
Cagnoni sarà presente nel cartellone del Festival della Valle D'Itria
2009 dopo il fortunato recupero nell'anno precedente del primo vero
successo del compositore, Don Bucefalo. La storia trascritta dal celebre
librettista Antonio Ghislanzoni nel 1885, fu composta dal Cagnoni nel
1893 ma non fu mai rappresentata vivente l'autore. Narra le gesta di Re
Lear, leggendario sovrano della Britannia che, approssimandosi la
vecchiaia, decide di dividere la Britannia fra le sue tre figlie e i
mariti che egli avrebbe loro assegnati, pur mantenendo l'autorità
regale. Il Re Lear è una novità assoluta: pur essendo di grande
interesse nell'evoluzione del melodramma italiano della fine
dell'Ottocento, ricco di influssi del tardo romanticismo europeo e del
movimento della Scapigliatura, non aveva mai visto le scene a causa
della morte del compositore subito dopo aver completato la partitura. |
|
[Dicono di Antonio Cagnoni dal DEUMM, Ed.UTET]
Fu allievo dapprima di F.Moretti, poi, dal 1842 al
1847, al Conservatorio di Milano, di P.Ray e di F.Frasi. Dal 1856 al
1863 ottenne il posto di maestro di cappella a Vigevano. Nel 1873 si
trasferì a Novara come direttore dell'istituto musicale di questa città
sostituendo Coccia. Nel 1887, alla morte di Ponchielli, ebbe l'incarico
di maestro di cappella a Bergamo in S.Maria Maggiore. Nello stuolo degli
operisti minori italiani del secondo Ottocento, Cagnoni raggiunse
notevole popolarità con due spartiti di genere giocoso, "Don Bucefalo" e
"Papà Martin", mentre il resto della sua produzione non oltrepassò
favori momentanei e successi di stima. Musicista fornito di un solido
mestiere artigianale (come era d'obbligo a quel tempo), Cagnoni
condivide tutti i limiti dei suoi colleghi: creatività occasionale,
scarse o nulle motivazioni culturali (col rischio di restar schiacciati
da soggetti troppo inpegnativi: si veda la "Francesca da Rimini"),
assoluta superficialità nel rapporto col testo. Per questo motivi il
musicista riuscì sufficientemente in lavori leggeri dove le possibilità
comiche, grottesche, caricaturali sopravanzavano di gran lunga
l'esigenza drammaturgica permettendo l'impiego (ancora gradito al
pubblico) di un linguaggio fra rossiniano e donizettiano, con agganci
fraquenti alla tradizione napoletana. Nel "Don Bucefalo" la goffa figura
del protagonista, un maestro di cappella borioso e spiantato, gli
consente di utilizzare una quantità di gags musicali non certo nuove, ma
comunque spassose se affidate ad un buon attore. In "Papà Martin",
commediola comico-sentimentale, la mano del musicista si fa più morbida,
la materia meno scontata: sono tuttavia, pregi troppo generici per
consentire a questi ed a molti altri spartiti coevi una esistenza meno
che effimera. |
|
Martina Franca, Palazzo Ducale, Info. 080.4805 100
http://www.festivaldellavalleditria.it |
|
RE LEAR di Antonio
Cagnoni
Tratto da :
Vedi ...
Chi l’ha detto che il Re Lear di Shakespeare sia un’opera
irrappresentabile? Il Festival della Valle d’Itria, che ama le sfide,
tenta l’impresa. Domenica 19 luglio 2009, ore 21, a Palazzo Ducale, ci
sarà la prima rappresentazione mondiale di Re Lear, l’ultima opera
musicata da Antonio Cagnoni, che dopo lo strepitoso successo dello
scorso anno con Don Bucefalo, torna al Festival martinese. Re Lear è
l’appuntamento centrale di questa 35^ edizione, realizzato in
collaborazione con la Fondazione Petruzzelli di Bari. Il direttore è
Massimiliano Caldi, la regia di Francesco Esposito.
Si tratta di una tragedia lirica in quattro atti e sette parti nata,
nel 1893, dal lavoro di sinergia tra il compositore lombardo ed il
celebre librettista Antonio Ghislanzoni. La fonte letteraria è il
King Lear, uno dei lavori più apprezzati di William Shakespeare. L’opera
che tutti i compositori dell’Ottocento avrebbero voluto realizzare.
L’opera che il grande Verdi non riuscì a terminare e che neppure Cagnoni
ebbe la fortuna di vedere rappresentata.
Dopo l’applauso unanime riscosso dal dramma Orfeo ed Euridice di Gluck,
il Festival martinese prosegue con una delle tragedie per eccellenza.
L’intricata trama shakespeariana viene raccontata con semplicità dal
regista Francesco Esposito, alla sua quarta edizione a Martina: “Il
vecchio Re Lear, deciso ad abdicare e delegare il potere alle sue figlie
e ai loro mariti, spartisce tra questi il suo regno con un atto solenne.
A questo scopo viene tenuto il rituale del Love Test: pubblicamente il
Re chiede alle figlie quanto sia grande il loro amore per lui. Le prime
due rispondono come previsto dal rituale, cioè con un atto di
sottomissione completo, mentre la terza, Cordelia, si ribella a questa
liturgia, che le appare vuota e inutile. Il Re, di fronte al grave
attentato alla sua regalità e al sistema stesso su cui poggia il suo
potere, disereda la figlia prediletta. Inizia così per il vecchio
sovrano un percorso di solitudine e di follia che, dopo il tradimento
delle figlie ubbidienti, riporterà Re Lear tra le braccia di chi
veramente lo ha amato”, ossia proprio Cordelia. Ma la riconciliazione
non durerà a lungo, perché Cordelia verrà ben presto uccisa “dalla fame
di potere”.
Strazio ed emozioni complesse condensate da Shakespeare in quest’opera
semplificata da Ghislanzoni e dallo stesso Cagnoni, che si riconferma
con il suo splendido stile, all’insegna della bella melodia e rispettoso
della tradizione musicale antica. Il compositore lombardo, in netta
controtendenza con il gusto del suo tempo, si lascia ispirare da grandi
scrittori come Shakespeare, componendo musiche “fluide”, dalle forme
chiare e immediate e con il coro, che introduce e commenta i momenti
cruciali dell’azione.
Il travestimento nel secondo appuntamento dell’edizione dei
travestimenti è quello del Matto, colui che non ha paura di dire la
verità, il giullare che seguirà fedelmente Re Lear fino alla fine e che
verrà perseguitato dal potere a causa dei suoi interventi irriverenti.
A Martina Franca, domenica 19 luglio, il Festival della Valle d’Itria
restituirà finalmente ad un pezzo di storia la sua meritata
immortalità.
Gli interpreti saranno: Costantino Finucci (Re Lear), Serena Daolio
(Cordelia), Eufemia Tufano (Regana), Rasha Talaat (il Matto), Danilo
Formaggia (Edgaro), Mebonia Vladimer (Conte di Gloster), Leone Maria (Gonerilla),
Coletta Gianni (Duca di Cornovaglia), Domenico Colaianni (Conte di Kent),
Cristian Camilo Navarro Diaz (Edmondo), il Coro Slovacco di Bratislava,
l’Orchestra Internazionale d’Italia. Direttore Massimiliano Caldi,
regista Francesco Esposito. Coreografie di Domenico Iannone, scene di
Nicola Rubertelli, costumi di Maria Carla Ricotti. |
|
 |
by Anders Wiklund (Anders Wiklund ha realizzato la
partitura che è stata utilizzata per la rappresentazione di Re
Lear nel 2009 al Festival della Valle d’Itria)
Donizetti Society Londra
Newsletter 108, October 2009, pp.4-5
Traduzione italiana a cura di
Mario Mainino
(membro della Donizetti Society sino al 1998)
Dopo avere avuto la Casa Ricordi, Milano come suo principale editore per
molti anni, Antonio Cagnoni nel 1866 si rivolse ad una casa editrice
appena fondata a Torino la Casa Editrice Giudici e Strada. L'azienda
nacque nel 1859 da Giovanni Battista Giudici e Achille Strada. Per più
di trenta anni questa impresa sarebbe stata la più importante di tutti
gli editori musicali torinesi. Dopo la morte di Strada (nel 1880) e
Giudici (1886) l'impresa passa ad Achille jr Strada, che scelse come
partner Ignazio Cazzini, per un breve periodo, e poi la casa editrice
milanese Arturo Demarchi, guidando l'azienda da solo fino alla sua morte
nel 1899, quando Paolo Mariani, prese il sopravvento.
Come aveva acquisito la società di Achille Tedeschi a Bologna, la casa
prese il nome imponente di "Riuniti Stabilimenti Musicali Giudici e
Strada, A. Demarchi, A. Tedeschi" di P. Mariani fu Claro. Aveva sede in
entrambe le città di Milano e Bologna e quando fu costituita a Milano
nel 1909 una Società Anonima il numero di titoli in catalogo era salito
a circa 22.000. Tra i compositori originariamente pubblicati dalla casa
editrice sono, ad esempio F. von Flotow (La fleur de Harlem [in italiano
Il Fiore di Harlem]), A.Ponchielli (I Mori di Valenza), Lauro Rossi
(Cleopatra) e molti altri.
Durante la prima guerra mondiale l'azienda fallisce e causa di problemi
di credito e viene rilevata da Luigi Stoppa nel 1920, che chiude
l'attività nel 1930. La procedura finanziaria della chiusura è stata
effettuata da Banca Cattolica di S. Antonio di Piacenza, che si rivolse
al Bibliotecario di quello che oggi è il Conservatorio "Nicolini" di
Piacenza per aiuto, così la biblioteca del Conservatorio "Nicolini"
di Piacenza ha ricevuto l'intero archivio musicale della ex Giudici &
Strada de da allora vi è li ospitato.
Ma tornando al Cagnoni, che ha passato alla nuova casa editrice musicale
pubblicare la sua opera "Claudia" nel 1866, la loro collaborazione
proseguì, nel 1878 per Francesca da Rimini così come nel 1884 per la
Messa funebre per 4 Voci e orchestra, che sono stati pubblicati dalla
ditta torinese. Gli autografi di questi pezzi sono ora reperibili nella
biblioteca del Conservatorio di Piacenza.
Nel 1880 Cagnoni rivolse il suo interesse a Re Lear di W.Shakespeare.
[..] E' ben noto come Verdi trascorse molti dei suoi anni creativi
cercando di trovare un libretto abbastanza buono per un Re Lear.
Quindi è più che intrigante che Cagnoni fosse poi il compositore che
Verdi scelse per scrivere il "Quid sum miser" nella Messa (a più mani)
in morte di Gioachino Rossini del 1869, e che Antonio Ghislanzoni,
librettista di Verdi per Aida, è stato quello che scrisse il libretto
per Lear di Cagnoni.
Dai registri della casa editrice si apprende che i diritti di Re Lear
erano nelle loro mani nel 1888 (Arena)[1],
ma alla morte di Cagnoni il 30 settembre 1896, l'opera non aveva ancora
avuto la sua prima.
Quattro anni dopo la morte del compositore Giudici & Strada pubblicò la
partitura vocale. Nonostante ciò ci sono due lettere scritte da Cagnoni
al M ° Pietro Sormani, Direttore sostituto di Toscanini e a Campanini al
Teatro alla Scala che aveva chiesto dettagli sulla opera
[2]. Dalla risposta di Cagnoni è evidente che qualche trattativa
era andata avanti con la Scala per la messa in scena Re Lear: c'erano
suggerimenti su quale parte della stagione sarebbe la più favorevole e
che Il Matto potrebbe essere considerato come un tenore Secondo. Le
lettere sono da febbraio 1895 e un anno prima della morte di Cagnoni,
nulla è successo e l'interesse della Scala finì in nulla.
Il materiale di Re Lear nella biblioteca del Conservatorio di Piacenza
consiste nella partitura autografa in quattro volumi, uno per ogni atto,
in parte autografo e una partitura vocale - le linee vocali scritte da
un copista mentre Cagnoni scrive la parte del pianoforte. Inoltre vi è
una serie completa di parti orchestrali (tranne che per la banda di cui
solo una "guida" è disponibile) tutte scritte a mano. Nell'esaminare
queste parti ci si rende conto che non sono mai state utilizzate, quando
li si apre il crepitio delle pagine appiccicate è un'eco del passato.
Le pagine sono bianche, senza la solita ombra giallastra. Nemmeno un
singolo segno di matita degli strumentisti. In altre parole: materiale
completamente vergine, raro da vedere. C'è anche un copia partitura in
quattro volumi con poche correzioni del copista (che ha anche inserito
le relative rettifiche corrispondenti all'autografo come Cagnoni stesso
aveva apportato quando ha preparato lo spartito vocale!). Non vi è
traccia di un libretto stampato e né alcuna menzione di qualsiasi testo
stampato in Caselli [3].
E 'interessante osservare Re Lear confrontandolo con l'ambiente musicale
in cui l'anziano compositore viveva. Negli anni 1880-90 il mondo
dell'opera italiana aveva sicuramente subito dei cambiamenti e influenze
che chiusero per sempre l'epoca d'oro del Primo Ottocento, sia Wagner
che l'opera francese erano entrati nei teatri lirici italiani e,
naturalmente, una nuova generazione di compositori italiani era arrivata
sulla scena: Puccini, Mascagni, Zandonai, Montemezzi, ecc.
Cagnoni era nato nel 1828, quando ancora l'opera era scritta con forme
che forse erano prevedibili, ma permettevano anche ai compositori di
allargare i confini di espressione musicale e drammatica. Cagnoni
portava in sé sia la forza che la debolezza del Teatro dell'Opera a
numeri chiusi, ora però privata del suo recitativi.
Come possiamo vedere dall'elenco che segue dei numeri in Re Lear, è
ovvio che Cagnoni potesse gestire il vecchio formato a numeri chiusi,
trasformandolo in una sequenza veramente personale:
ATTO PRIMO
n.1 Introduzione
ATTO SECONDO
n.2 Scena ed Aria (Edgardo)
n.3 Scena e Duetto (Cordelia, Edgardo)
n.4 Finale 2°
ATTO TERZO
n.5 Preludio, Scena e Romanza (Edgardo)
n.6 Coro e Tempesta
n.7 Scena e Quartette (Matt, Edgardo, Lear, Gloster)
n.8 Coro, Scena e Duetto (Cordelia, Lear)
ATTO QUARTO
n.9 Scena ed Aria (Regana)
n.10 Scena ed Duetto (Regana, Edgardo)
n.11 Coro e Ballabile
n.12 Scena e Finale ultimo
L'equilibrio dell'opera è evidente, il n.1 e il n.12
creano le delimitazioni esterne, gli Atti 2 e 4 formano la cornice per
la parte centrale dell'Atto 3 con i quattro numeri.
Una forma che riflette anche la portata drammatica dello stesso gioco
con un forte atto terzo centrale. Cagnoni li creò con una musica che ha
il suo punto di partenza nel passato, nel 1840, con l'eleganza
drammatica di Donizetti e il forte accento drammatico di Verdi, legata
all'attuale cromatismo wagneriano, una miscela della sottile armonia
francese di un Gounod e un Massenet e tratti del verismo e del
sentimento pucciniano.
A pieno titolo, Re Lear diventa così il "Canto del Cigno" dell'Opera
italiana del 19° secolo!
[1]
S..Arena: L'archivio delta casa editrice Giudici & Strada presso il
Conservatorio "Nicolini" di Piacenza. Fonti Musicale Italiane, 5, 2000,
pp. 249-269
[2] Sono grato a
Alexander Weatherson che mi ha fatto notare l'esistenza di queste
lettere nel Gallini Catalogues dal 2001 e 2003.
[3] Caselli, A.: Catalogo
delle opere liriche pubblicate in Italia, Olschki Ed., Firenze, 1969
Tratto da
http://www.donizettisociety.com/Newsletters/articlenews108.htm |
La
Biblioteca conserva la Raccolta Antonio Cagnoni (Godiasco, Pavia, 1818 -
Bergamo 1896), musicista e direttore della Cappella musicale di Santa Maria
Maggiore di Bergamo. La raccolta, giunta in Biblioteca nei primi anni di questo
secolo, comprende soprattutto manoscritti musicali, diplomi, attestazioni di
merito e lettere. Corrispondenza Antonio Cagnoni Sono raccolte in due volumi di
"Diplomi e corrispondenza diversa" (MMB 352-353) 204 lettere e due post mortem
(1858-1892) relative all'attività musicale, a rapporti con editori e a incarichi
professionali.
Antonio
Cagnoni - libretti
| Invito all'Opera Antonio Cagnoni di
Maurizio Giarda Cagnoni fu uno dei più interessanti operisti di metà 800.
Nacque a Godiasco (Pavia) nel 1828, studiò a Milano con Lauro Rossi e a 18
anni scrisse due opere “I DUE SAVOIARDI” e “ROSALIA DI SAN MINIATO”, e nel
1847 con “DON BUCEFALO” colse un vero trionfo e resterà la sua opera più
popolare: è una commediola ambientata nel mondo dell’opera, si prova una
nuova opera e il compositore Bucefalo è innamorato della prima cantante,
Rosa, che però ama un giovane tenore; dopo una girandola di colpi di scena
Bucefalo si deve arrendere. Si sentono echi di Donizetti nella musica, tra
le pagine più valide l’aria di Rosa, “colui che mi dice”, la lezione di
canto di Bucefalo a Rosa, la canzone popolare dei contadini “sorgi o notte
amica”, il duetto Rosa-Carlino. Continua col genere comico scrivendo
“AMORI E TRAPPOLE”, “IL TESTAMENTO DI FIGARO”, “LA FIORAIA”, tipiche
commedie ilari, sentimentali: con “LA VALLE D’ANDORRA” tenta il genere
semiserio mostrando una notevole tecnica strumentale, e con “CLAUDIA” del
1866 tenta il genere drammatico con buoni risultati. Nel 1870 ha un altro
grande successo con “PAPÀ MARTIN”, di tono sentimentale, patetico. Altre
opere di rilievo sono “IL VECCHIO DELLA MONTAGNA” e “MICHELE PERRIN”,
commedia sociale che porta sulla scena i problemi del lavoro, il
proletariato milanese, il vano tentativo di un giovane di campagna di
lasciare la campagna e inserirsi nel mondo milanese. Dopo il 1870
nell’opera italiana avvengono grandi mutamenti e nuovi orientamenti,
arrivano le opere di Wagner, Carmen, Boito, col “MEFISTOFELE”, tenta un
opera filosofica, si trattano grandi temi spirituali, metafisici; anche
Cagnoni tenta di aggiornarsi, del 1874 è “UN CAPRICCIO DI DONNA” che si
svolge a Parigi nel 700, del 1878 “FRANCESCA DA RIMINI”, la sua opera più
impegnativa, il tentativo di superare schemi convenzionali. Di particolare
rilievo drammatico il finale con l’uccisione di Paolo e Francesca,
notevole anche la caratterizzazione ambientale medievale. Si sente un
influsso di Wagner nella strumentazione e accenti preveristi. Muore nel
1896. tratto da
Invito all'Opera Antonio Cagnoni
di Maurizio Giarda reperibile all'indirizzo :
http://www.primonumero.it/musica/classica.php?id=181 |
Elenco delle opere
rappresentate di
Antonio Cagnoni
Tratto dalla Gazzetta musicale di Milano 1896
| N. |
Anno |
Mese/gg |
Città |
Teatro |
Titolo |
Genere |
Poeta |
1 |
1845 |
28-feb |
Milano |
Conservatorio di
Musica |
Rosalia di S.Miniato |
semiserio |
Bassi |
2 |
1846 |
15-giu |
Milano |
Conservatorio di
Musica |
I due Savoiardi |
semiserio |
Tarantini |
3 |
1847 |
28-giu |
Milano |
Conservatorio di
Musica |
Don Bucefalo |
buffo |
Bassi |
4 |
1848 |
26-feb |
Milano |
Re |
Il testamento di
Figaro |
buffo |
Bassi |
5 |
1850 |
17-apr |
Genova |
Carlo Felice |
Amori e trappole |
buffo |
Romani |
6 |
1851 |
07-giu |
Milano |
Canobbiana |
La Valle d'Andorra |
semiserio |
Giacchetti |
7 |
1852 |
08-mag |
Milano |
S.Radegonda |
Giralda |
semiserio |
Giacchetti |
8 |
1853 |
24-nov |
Torino |
Nazionale |
La Fioraia |
buffo |
Giacchetti |
9 |
1856 |
18-ott |
Genova |
carlo Felice |
Le figlie di Don
Liborio |
buffo |
Guidi |
10 |
1860 |
07-set |
Torino |
Carignano |
Il vecchio della
montagna |
serio |
Guidi |
11 |
1864 |
12-mag |
Milano |
Filodrammatici |
Michele Perrin |
buffo |
Marcello |
12 |
1866 |
20-mag |
Milano |
Canobbiana |
Claudia |
serio |
Marcello |
13 |
1868 |
18-gen |
Roma |
Argentina |
La Tombola |
buffo |
Piave |
14 |
1870 |
10-mar |
Genova |
Carlo Felice |
Un capriccio di donna |
serio |
Ghislanzoni |
15 |
1871 |
04-mar |
Genova |
Nazionale |
Papà Martin |
buffo |
Ghislanzoni |
16 |
1874 |
10-ott |
Lecco |
Sociale |
Il Duca di Tapigliano |
buffo |
Ghislanzoni |
17 |
1878 |
19-feb |
Torino |
Regio |
Francesca da Rimini |
serio |
Ghislanzoni |
Antonio
Cagnoni - libretti
|